25 Marzo 2023 – Redazione
La Sardegna è nota per la sua ricchissima macchia mediterranea che presenta numerose piante aromatiche e piante officinali. Molto prospera è l’area della Gallura nella quale è possibile praticare un vero e proprio esercizio dei sensi: provate a chiudere gli occhi e a percepire tutte le essenze olfattive in una vegetazione boschiva a ridosso del mare; o meglio ancora, fatevi condurre da una guida esperta la quale vi sottoporrà bendati una serie di essenze che dovrete riconoscere, e che di conseguenza apprenderete. Profumi inconfondibili e colori che variano a seconda della stagione, vediamo quali sono le più famose erbe aromatiche e piante officinali della Gallura. Intanto specifichiamo che le erbe officinali sono un insieme di piante differenti trasformate dall’uomo tramite lavorazioni con lo scopo di poterne godere delle singole proprietà benefiche. Ogni pianta officinale ha quindi le proprie caratteristiche, nasce e cresce in un determinato habitat, ha i suoi tempi di raccolta ed appunto anche i suoi utilizzi. La Sardegna, e quindi anche la Gallura, è popolata dalla macchia mediterranea, ovvero quell’ecosistema tipico del bacino del Mar Mediterraneo, vegetazione influenzata dal mare e dal clima con estati secche e torride ed inverni miti. Si stima che le specie vegetali autoctone siano circa 2700 posizionando la Sardegna al secondo posto in questa speciale classifica tra le regioni italiane. Alcuni tra questi endemismi, fenomeno per cui alcune specie vegetali sono esclusive di un determinato territorio, sono condivisi ad altre isole del Mediterraneo come la Corsica, la Sicilia e le Baleari.
L’utilità della macchia mediterranea è quella di svolgere una difesa dall’erosione del suolo contribuendo a preservare gli ambienti costieri e quindi il paesaggio.
Fatta questa doverosa premessa, andiamo a vedere assieme le più famose erbe e piante officinali della Gallura.

Piante Officinali in Gallura: le Eccellenze
Se venite in Gallura vi imbattete subito nei forti e caratteristici aromi della macchia mediterranea: è comune infatti sentirsi dire che la Gallura abbia dei profumi inconfondibili e riconoscibili, che si individuano sia come si apre il portellone dell’aereo in Olbia, sia con l’approccio via nave dentro il Golfo di Olbia. E queste bellissime sensazioni diventano più forti con l’inoltrarsi nel paesaggio gallurese, magari della Costa Smeralda, con le spiagge precedute da stupende distese di vegetazione che si avvicinano alla sabbia degli arenili. Arrivare al mare è un preludio meraviglioso grazie alla presenza di ginepri, lavande, lentischi e ginestre ed in primavera ed inizio estate prevale il colore giallo ed il verde intenso, che va a schiarire con l’arrivo dei mesi più caldi. Ma abbiamo anche il bianco e il rosa dei cisti e delle eriche, il rosso dell’euforbia e l’azzurro del rosmarino. Ma le piante ed erbe officinali in Gallura, oltre ad avere la loro utilità all’interno della macchia mediterranea preservandone le coste ed i paesaggi, ed oltre ad essere una parte integrante nella bellezza dell’ecosistema, svolgono anche un ruolo di protagonista nella cultura popolare e sono utilizzate per scopi curativi e anche per realizzare manufatti. Le piante officinali che troviamo in Gallura sono in ordine alfabetico: alloro, cappero, caprifoglio mediterraneo, cisto, erica, euforbia, ginepro, ginestra, lentisco, mirto, oleandro, olivastro, rosmarino, palma nana e pungitopo. Mentre l’erboristeria officinale più famosa in Sardegna si trova proprio in Gallura, precisamente a Luogosanto, nella Strada Provinciale 14 Arzachena Luogosanto Balaiana, e si chiama Erboristeria Officinale Sub Moloc Sardegna: lo slogan dell’erboristeria è “l’erboristeria come atto agricolo, coltiviamo, raccogliamo, traformiamo piante officinali dal 1980”. E dopo questa panoramica, siamo pronti ad addentrarci nel conoscere le erbe officinali più famose della Gallura.
Elicriso
Caratteristico della macchia mediterranea, è abbondante nelle zone aride in prossimità del mare, e nei luoghi rocciosi e pietrosi. In Gallura fiorisce in aprile-maggio e si presenta con base lignificata e di altezza intorno ai 30-50 cm con fiori profumati di colore giallo oro molto aromatici. Già apprezzata in epoca romanica e nel Medioevo in quanto pianta aromatica, i diversi preparati di elicriso possono trovare impiego nelle malattie respiratorie, reumatiche e per curare le ustioni. Le foglie in cucina si utilizzano per aromatizzare i cibi e a scopo ornamentale.
Finocchietto selvatico
Il finocchietto selvatico è un arbusto erbaceo spontaneo della macchia mediterranea, appartenente alla famiglia delle ombrellifere, è rinomato per le sue proprietà aromatiche e per questo molto utilizzato in cucina. La pianta si compone di un fusto ramificato che può arrivare anche a 2 metri, foglie filiformi verdi e fiori gialli disposti a ombrello. Si adatta a terreni aridi esposti al sole e riparati dal vento, mentre non sopravvive in caso di gelate. Si utilizza in cucina per aromatizzare ragù e formaggi e dalle foglie macerate nell’alcool puro si può ricavare un buonissimo liquore. Le proprietà fitoterapiche del finocchietto sono digestive, antisettiche e antispasmodiche.

Mirto
Il mirto è probabilmente la pianta più famosa simbolo della Sardegna per via del rinomato liquore che si ricava. Ed il mirto cresce in grande abbondanza in tutta la Sardegna ed in tutta la Gallura. I cespugli di mirto hanno foglie profumatissime e bacche violacee o nero-bluastre ed il suo arbusto può raggiungere anche 3-5 metri di altezza. Durante il periodo estivo la pianta produce fiori bianchi con 5 petali dai quali si produce anche un miele che ha proprietà antibatteriche. Sin dal Medioevo il mirto è stato usato per scopi ornamentali, culinari e terapeutici; il suo olio essenziale ha proprietà antisettiche e balsamiche, infatti in fitoterapia la pianta è usata come sedativo in caso di bronchite. Grazie alla sua azione tonica è utilizzato anche come ingrediente di creme cosmetiche.
Timo
Il timo è una pianta mediterranea che nasce spontaneamente con fusto legnoso di 10-30 cm di altezza e ramificazioni con foglie verde-grigio e che fiorisce nei mesi primaverili e in prima estate. I fiori e le foglie del timo contengono un principio attivo con proprietà digestive, lassative, antisettiche e antinfiammatorie. In cucina accompagna minestre, carni, sughi e salse, e specialmente con le patate al forno. All’olio essenziale del timo vengono attribuite proprietà antibatteriche che sono un perfetto alleato per dermatiti e disinfettare punture di insetto. In Gallura si trova principalmente nel monte Limbara.

Alloro
L’alloro è una pianta spontanea che si trova nelle campagne galluresi e sarde, ed è un albero sempreverde con foglie ovali e lucide. Le sue bacche e le sue foglie in particolare si possono raccogliere tutto l’anno ma risultano ricche di proprietà benefiche in particolare se raccolte in inverno ed all’inizio della primavera. L’alloro viene utilizzato prevalentemente in cucina, è ricco di proprietà antisettiche, antiossidanti, antidigestive e antitumorali; le sue foglie sono anche fonte di vitamina C, quindi è un efficace antiossidante che contrasta l’azione dei radicali liberi. Utilizzate fresche, le foglie di alloro hanno un elevato contenuto di acido folico, fondamentale nel periodo di gravidanza, e sono una fonte anche di vitamina A, indispensabile per la salute della vista e della pelle. L’alloro può essere utilizzato come infuso di foglie, per contrastare bronchiti e influenze, infuso di bacche, per disturbi circolatori, decotto di bacche, per contrastare i sudori estivi, ed in cucina accompagna piatti a base di carne.

Corbezzolo
Il corbezzolo dona un tocco di colore riconoscibile nella macchia mediterranea grazie alle piccole bacche di colorazione gialla o rossa nel periodo autunnale a seconda del grado di maturazione. Ma il corbezzolo non ha solo frutti rossi o gialli, ma ha anche foglie verdi e fiori bianchi; l’arbusto è sempreverde e fiori e frutti possono essere contemporanei. I frutti del corbezzolo sono utilizzati nella cucina gallurese e sarda per la produzione di mieli, confetture e dolci, oltre che per la produzione di grappe, liquori e vini. Al corbezzolo sono riconosciute proprietà emollienti utili per regolarizzare le funzioni intestinali ed hanno azione antiossidante e antinfiammatoria. Le foglie e le radici del corbezzolo possono essere utilizzate nella preparazione di tisane e decotti.

POTETE SEGUIRCI ANCHE SU TELEGRAM ⤵️
https://t.me/mercurius5giornale






















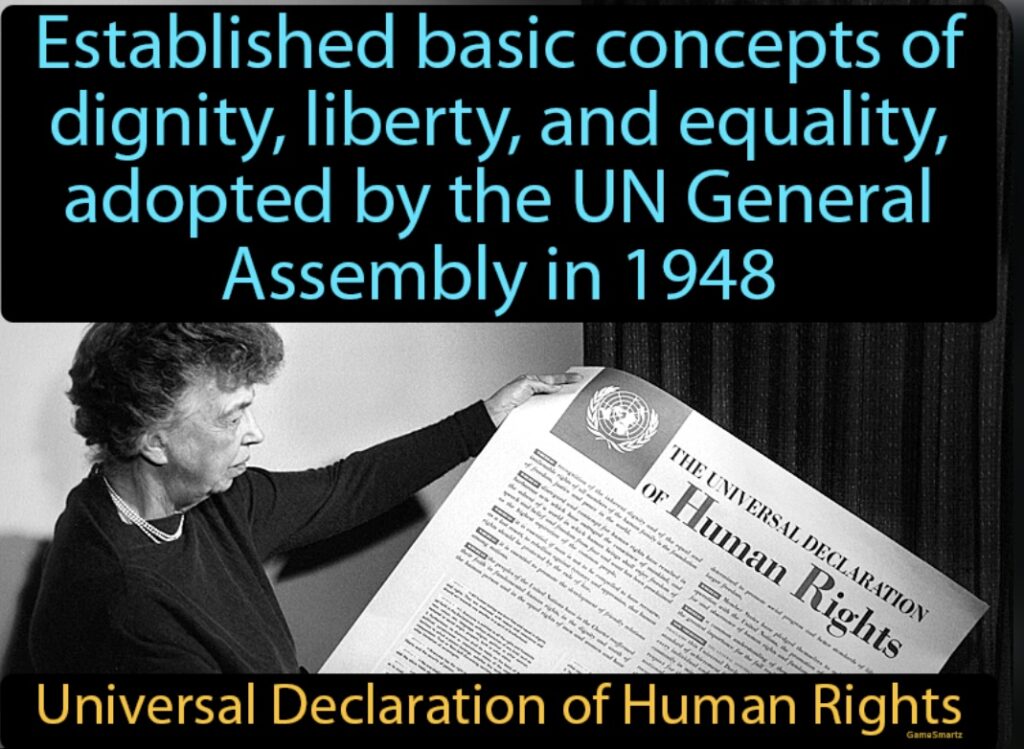

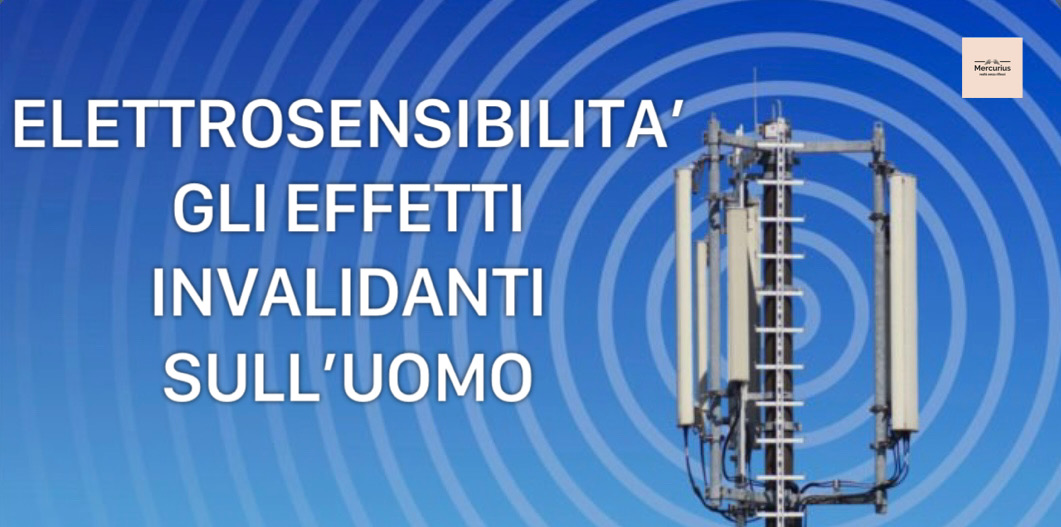




 Cercando l’archivio di Time magazine per una ricerca, mi sono imbattuto nella copertina del numero 24 del 12 Giugno 1933. La foto è quella di un distinto signore dai capelli neri, lineamenti marcati e un sigaro in bocca. Sotto la foto il nome: Ferdinand Pecora.
Cercando l’archivio di Time magazine per una ricerca, mi sono imbattuto nella copertina del numero 24 del 12 Giugno 1933. La foto è quella di un distinto signore dai capelli neri, lineamenti marcati e un sigaro in bocca. Sotto la foto il nome: Ferdinand Pecora.















 La farina di miglio è scura, pesante e leggermente amarognola. Il miglio è un cereale senza glutine molto digeribile ma con un sapore particolare, per questo è meglio usare lo sfarinato in combinazione con altre farine. Si presta alla preparazione di polente e crepes, dolci o salate e può essere aggiunto ai biscotti e in piccole dosi anche al pane.
La farina di miglio è scura, pesante e leggermente amarognola. Il miglio è un cereale senza glutine molto digeribile ma con un sapore particolare, per questo è meglio usare lo sfarinato in combinazione con altre farine. Si presta alla preparazione di polente e crepes, dolci o salate e può essere aggiunto ai biscotti e in piccole dosi anche al pane.













