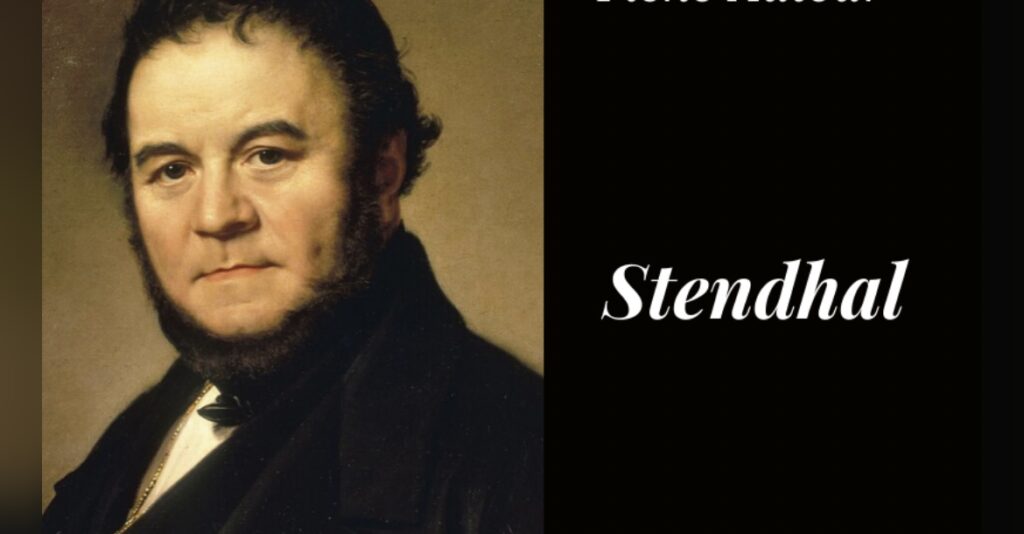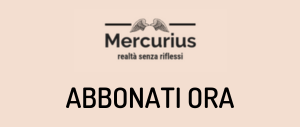26 Maggio 2023 – Redazione
Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 un furgone Fiat Fiorino imbottito di 277 chili di tritolo esplose in via dei Georgofili, a Firenze, accanto alla Galleria degli Uffizi. La strage, compiuta da Cosa Nostra, uccise 5 persone (e ne ferì 48): i coniugi Fabrizio Nencioni (39 anni) e Angela Fiume (31 anni), le loro figlie Nadia (9 anni) e Caterina (appena 50 giorni di vita) e lo studente Dario Capolicchio (22 anni). L’attentato fa parte della scia delle altre stragi del 1992-1993 che provocarono la morte di 21 persone (tra cui i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino) e gravi danni al patrimonio artistico. Nel 2002 la Cassazione ha confermato 15 ergastoli per la strage: tra i condannati Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro.
In occasione dei 30 anni da quel terribile attentato, il «Corriere» ha incontrato a Firenze Luigi Dainelli, parente della famiglia Nencioni e presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili; il direttore degli Uffizi Eike Schmidt e Anna Maria Petrioli Tofani, all’epoca dei fatti direttrice degli Uffizi.
Luigi Dainelli, lo zio delle piccole Nadia e Caterina
Incontriamo Luigi Dainelli a La Romola, frazione di San Casciano val di Pesa (Firenze) dove si trova il parco dedicato a Nadia e Caterina Nencioni, le bambine vittime della strage insieme ai loro genitori e allo studente Capolicchio. In questa frazione nacque Fabrizio Nencioni, che poi si trasferì a Firenze con la moglie e la famiglia, quando alla moglie offrirono un posto come custode dell’Accademia dei Georgofili. «Il 23 maggio avevano battezzato Caterina e si fece la festa qui — ricorda Nencioni — nella solita chiesa a Firenze, il sabato dopo, ci furono i funerali: si passò da una grande gioia a loun dolore immenso». Nel video, Dainelli ripercorre quella notte e poi racconta: «Si capì quasi subito che non si trattò di una fuga di gas, c’era odore di polvere da sparo e il Fiorino era disintegrato, addirittura una parte del motore finì dall’altra parte del fiume Arno. Poi il giorno dopo trovarono il cratere dov’era stata parcheggiata l’autobomba». L’uomo poi ci racconta anche la nascita della poesia «Il tramonto», scritta da Nadia pochi giorni prima di morire. E che, lo scorso 16 gennaio, è tornata a essere ricordata dai media per l’arresto di Matteo Messina Denaro, intitolato proprio «Operazione Tramonto», in ricordo della piccola vittima di 9 anni, su volontà del colonnello Lucio Arcidiacono, che ha guidato la squadra di «cattura» del boss. Dice Dainelli: «In via dei Georgofili i tramonti non si vedono, quindi quando Nadia veniva a La Romola forse ne era rimasta affascinata: così ha scritto questa poesia. È rimasta conservata in un quaderno a scuola e la maestra ce l’ha restituita. Oggi io la porto nelle scuole per raccontare». La poesia porta la data del 24 maggio, 3 giorni prima dell’attentato: «Il pomeriggio/ se ne va./ Il tramonto si avvicina,/ un momento stupendo,/ il sole sta andando via (a letto)/ è già tutto finito».
Eike Schmidt: «Un restauro di valore estetico, ma anche morale»
Il direttore della Galleria degli Uffizi ci accoglie nei Depositi del museo dove sono conservate le due opere di Bartolomeo Manfredi (1582-1622; il suo «Giocatori di carte» è stato restaurato 25 anni dopo la strage) e di Gherardo delle Notti(1592-1656) che sono state quasi distrutte dall’attentato, poi recuperate dopo un restauro importante durato anni, e che ora sono esposte permanentemente per commemorare i 30 anni dall’attentato. «Immediatamente dopo l’attacco si è costituita l’Associazione Amici degli Uffizi che hanno organizzato una raccolta fondi per poter restaurare le opere. All’epoca più di 500 opere rimasero ferite dalla forza dell’esplosione — racconta il direttore —. Le due opere restaurate presentavano dei frammenti neri che sembravano cenere, e che in realtà erano parti bruciate della tela; poi un computer li ha rimessi insieme. Questi quadri hanno molte lacune oggi, parti che non esistono più e che sono andate bruciate per sempre. Restano piccoli frammenti che sono stati messi insieme. Il processo della ricostruzione materiale di quello che è rimasto rappresenta un forte segno contro la distruzione e la criminalità organizzata. Questo è un lavoro non solo di natura storica ed estetica, ma anche morale.»

Anna Maria Petrioli Tofani, l’ex direttrice che riaprì gli Uffizi in soli 20 giorni
«Quella notte fui svegliata da una telefonata angosciata dai custodi della Galleria che mi dissero che era avvenuto un episodio di cui non si capiva l’origine». A raccontare le prime impressioni di quella notte è Anna Maria Petrioli Tofani, direttrice degli Uffizi dal 1987 al 2005: «Tremai all’idea di entrare al museo quando mi resi conto della devastazione. I danni maggiori erano all’altezza dell’accesso al Corridoio vasariano, dove erano esposti i dipinti della corrente caravaggesca, e dove c si trovavano i tre dipinti che andarono distrutti in maniera irreparabile». Nonostante i gravi danni, tutto il personale lavorò giorno e notte e riuscì a recuperare in soli 20 giorni, racconta ancora l’ex direttrice, il 60% del museo: «Venti giorni dopo il presidente del Senato Giovanni Spadolini presenziò all’apertura. Poi per arrivare alla riapertura totale occorsero ancora un paio d’anni», ricorda. E infine: «Perché colpire proprio gli Uffizi? Si cercò di creare sconforto nella popolazione, di provocare un senso di pericolo e di impotenza , che forse avrebbe facilitato certe operazioni di natura politica. Gli Uffizi, poi, erano un nome noto in tutto il mondo e li hanno scelti per la loro visibilità. Quell’attentato scavalcò anche un fosso: fino a quel momento le opere d’arte erano considerate sacre, la testimonianza di una civiltà, le storiche e psicologiche di una popolazione».
FONTE: Corriere della Sera
UNISCITI A MERCURIUS5 ⤵️